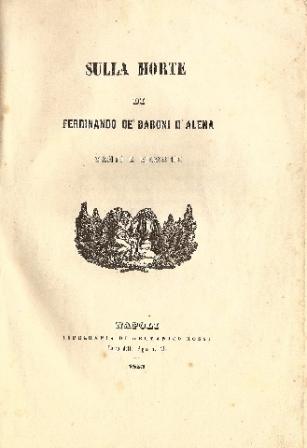
Ode
in morte di Ferdinando dei Baroni d’Alena.
Ferdinando d’Alena, figlio di Francesco e di Elisabetta de Capoa, morì giovanissimo all’età di venti anni. Tuttavia, nel suo breve passaggio in questa vita, seppe dare dimostrazione di tante e tali virtù, che non passarono inosservate. Il Canonico Florindo Battista, nel 1853 pubblicò un libretto (Tipografia Germanico Rossi, l.go delle Pigne, 11, Napoli) nel quale raccontava la vita del giovane Ferdinando, dedicandogli un’ode. Il contenuto del libretto, unitamente a copia dello stesso, che purtroppo è privo delle pagine da 17 a 25, mi è stata fornita dall’Avv. Giuseppe de Cristofaro.
![]()
A
TE
ORNAMENTO
CARISSIMO DELLA PATRIA TERRA,
LUIGI
DE'
BARONI D'ALENA
CHE
TANTO ONORI L'ALTA MAGISTRATURA
E
SENZA MODO TI DUOLI DELLA PERDITA
DEL
QUADRILUSTRE GIOVANETTO
CHE
NATO DEL FRATEL TUO PER VIRTÙ T'ASSOMIGLIAVA
QUESTI
CANTI E MEMORIE
DA CALDO E SINCERO AFFETTO INSPIRATE
GLI
AMICI DELL' ESTINTO
RlVERENTEMENTE
CONSACRANO
![]()
NOTIZIA
INTORNO
ALLA VITA ED AI COSTUMI
DI
FERDINADO
DE' BARONI D' ALENA
Frosolone
nel Sannio gli fu cuna - Ei nacque a
dì 18 giugno 1832 da Francesco de' Baroni d' Alena e dalla nobile
Signora Elisabetta de Capoa. Come il suo cuore fosse
educato ne' primi anni della vita non occorre dire, quando
è noto che parenti siano i suoi. I quali
conoscendo che
la carriera delle nostre azioni comincia
nella famiglìa, prima
palestra di virtù, e la religione, secondo il Filosofo da Verulamio, è l'aroma
che deve preservare i costumi e le scienze dal corrompersi: sì dettero
con incessanti cure e più ancora con
l’esempio, a formargli i costumi sulle leggi
più sante della religione e della morale.
I
semi affidati a vergine cuore dalla buona educazione
sono di germoglio immortale. Epperò a nove anni il giovanetto,
bello come un Angelo, aprì il suo cuore immacolato
ad ogni virtù, e caldeggiò nell’animo l’amore verso
Dio. E perchè chi si pregia d'amar Dio, d’amar l’umanità,
d'amar la patria, deve somma riverenza, sentita
gratitudine, alto rispetto e gentile dimostrazione di tutti
quei sentimenti, che inspira la religione, a coloro, pei
quali è divenuto creatura di Dio,
uomo, cittadino; egli amò
fino al delirio i bennati genitori, e specialmente la
pia e virtuosa madre, che gl'informò
l'intelletto ed il cuore,
instillandogli per tempo nell'animo quanto v'ha di più eccelso e gentile. E se
la identità del sangue e la somiglianza di molte abitudini tra fratelli e
sorelle genera naturalmente una
forte simpatia, a distruggere la quale non
si richiede meno che un orribile egoismo, Ferdinando d'Alena amò
svisceratamente i suoi fratelli e le sue sorelle.
Formato
siffattamente il cuore del giovanetto tra le domestiche pareti, dove splendono
purezza veramente illibata di
costumi, non interrotto esercizio di religione e carità
evangelica verso il prossimo, era d'uopo di educare
il suo intelletto. E gli amorosi genitori di Ferdinando d'Alena,
sapendo bene che una nobile cuna non è per sè sola
un titolo a meritare la pubblica stima, senza che si coltivi
l'ingegno (come sciaguratamente opinava il padre di Cartesio),
ma la scienza solamente è quella Diva benefica, che fa passare attraverso de'
secoli la fama de' mortali, e li
rende eterni; essi fermarono di mandare altrove
il docile figliuolo, il quale stretti
al seno i suoi cari genitori, se ne svelse dolorosamente, e nel dì 28 ottobre
del 41
bramoso di gloria entrava nel Collegio Sannitico. Non
è a dire con quanto affetto ivi
ponesse mano allo studio delle amene lettere, nelle quali molto innanzi egli
andò; ma come quegli che abbondava
principalmente di vena speculativa, si rese chiaro nelle filosofiche e
matematiche discipline. In tutti i
pubblici esami il nostro giovine ottenne
il plauso dell'universale; e premio di sua valentia nelle filosofiche scienze fu
la medaglia d'oro. Non fu secondo ad altri
nell’arti belle, ma sopratutto gli andò a sangue il
disegno; e tra le molte figure delineate a vaghissime sfumature,
le quali restano argomento di quanto ei potea in
questa bella fra le arti, è degna di
somma lode quella che ne
rende le forme dell'angelico Gonzaga eseguita a pastello
nero, ed ammirevole nella morbidezza dello sfumo. Nel Collegio l'ortodossia fu
in lui sempre pura; e 'l germe di religione
schietta e profonda locato dalla mano materna
nel cuor di lui fin dal primo albore
della ragione, si rese allora più
fecondo per opera delle scienze speculative. Epperò
non fu egli della schiera di tanti azzimati saccentuzzi,
i quali appena entrano nel santuario della filosofia (cui
poco o nulla intendono) abbaiano contro il cattolicismo; e inanellando
i loro mustacchi, sputano tondo, e gridano come
lo stolto: non evvi Dio([1]):
o tutto al più tengono la religione
per un affetto solitario dell' animo, o una semplice
speculazione della mente, quasi che ella non debba informare tutte
le nostre potenze, e possa concepirsi altrimenti
che come un primo vero e un amore visibile e perpetuo sopra la terra. No; anzi
la religione, la quale custodisce e
giustifica il cuore, ed è apportatrice di letizia e
di gaudio ([2])
vieppiù si fece donna di lui, a misura che
ei venne incarnando la scienza del pensiero, la quale, secondo
il bellissimo dettato di Bacone, quando è superficiale
e sofistica mena all'ateismo; ma quando penetra oltre
la buccia delle cose, e si mostra
solamente amica magnanima della verità, essa è la colonna di nostra
religione ed il sostegno del
cattolicismo. Conciossiacchè la religione e la
filosofia sono - è vero - una dualità
distinta, ma unita e ac-cordante, perchè ingenerata da un solo principio, cioè
dal-l'atto creativo. Perciò le due
cose sono distinte, ma inseparabili:
diverse, ma analoghe; consonanti. ma non unisone,
e insieme conglutinate, senza mischianza e confusione di sorta; e chi tra loro
induce divorzio le tronca, le altera, le rende inerti, mutila l'opera divina,
contraddice alla Provvidenza, e
introduce lo scisma nel seno medesimo dell'azione creatrice. Guai a coloro che
scompagnano con
ardita sofistica la religione dalla scienza del pensiero!
Compiuti
i filosofici studi, la vita del giovine scorreva
placidamente tra i sublimi diletti che le scienze e l'arti
belle danno a' cultori delle medesime. Emulo, ma non invidioso,
nutrì per tutti i giovani del Collegio sincera amicizia,
la quale, essendo il bello ideale della fratellanza,
dà all' anima un certo che di
poetico, di sublimemente forte, senza di cui difficilmente si eleva al disopra
del fangoso terreno dell'egoismo. Ei sentì sempre vivo questo nobile
affetto, quest’arcana simpatia, la quale è il vincolo
che unizza il nostro genere nella
successione de' secoli, introduce fra
i suoi vari membri un legame di continuità, e
ne fa come un solo individuo. Bello della persona, a diciassette
anni un secolo di sanità e di vita stava sculto nella
vigoria dei suoi muscoli, nel rigoglio de' suoi movimenti,
nella limpidezza del suo sangue. Ma Dio accenna:
ed al suo cenno ecco tornare in polvere l' animata argilla ..... Era il dì 15
aprile del 49. Il giovanetto sì vigoroso
e leggiadro cadde infermo; ed il male inemendabile, che poscia l'estinse, gli
ebbe penetrato talmente le ossa e le
midolle, che egli a dì 30 maggio dello stesso anno
fu astretto di abbandonare tra le lacrime il Sannitico Collegio, e tornare agli
amplessi de' suoi cari. Nella patria il
male infierì e vani tornarono i rimedi della medica arte.
«Il male del giovine era indefinibile, perchè, consistendo
nelle più riposte fonti della vita, era, come la vita
stessa, inesplicabile. Le ossa si
rammollivano e disfacevano l'un di più che l'altro, e negavano il loro ancorchè
debole sostegno alle misere carni che
le ricoprivano. Le carni stesse
dimagravano e isterilivano ogni dì, perchè i visceri
del nutrimento ne rifiutavano loro l'assimilazione.»
Il
giovine a passo lento camminava verso il sepolcro; e nella
disperazione d'ogni umano rimedio, i genitori sconsolati
si posero in cuore di mandarlo a Napoli, nella fidanza
che la dolcissima terra della Sirena avesse potuto rifiorirlo
di salute. Non fu egli già duro, o indocile al loro affetto;
e benchè insino alle lacrime dolentissimo, a dì 10
maggio del 51 si divise da' suoi cari, e si avviò per alla volta
della Metropoli. Quivi giunto è incredibile a dire quanto
si confortasse e ricreasse. L'olezzo dei fiori, il cielo sempre
ridente per limpidissimo azzurro, i soli tepidi e qua-si
orientali dell'inverno, le profumate aurette che carezzano la marina, la
salubrità squisitissima dell'aria gl'infusero a prima giunta un nuovo raggio
di vita; tal che nell'ebbra
stupefazione di quell'aure odorose ed incantatrici
rinasceva nel cuor di lui la speranza di vedere sconfit-to
il terribile morbo, che gli avea sfrondato il fiore della bella giovinezza, e
minacciava ad ora ad ora di gittarlo nel sepolcro. Vana speranza! Iddio aveva
scritto nel suo registro adamantino che morte innanzi tempo togliesse di vita il
verecondo giovanetto .... e la sillaba di Dio non si can-cella.
Tutti i consigli de' più gravi e sperimentati medici che
onorano la patria di Cirillo, fra i quali l'aureo Ramaglia, cara gemma del
nostro Sannio, tutti i più vigorosi ed estremi
partiti della scienza; come pure le balsamiche acque d'Ischia,
non valsero a fermare, o a pur mitigare l' improba
mano dell'inesorabile morbo, che veniva spietatamente
distruggendo uno de' dilicati lavori della natura. Valicato per
un gran mare di dolore un anno e tre mesi nella bella
Napoli, con la disperanza di più riaversi; e vedendo tutto il misterioso
circolo della vita, che a grande stento si movea,
fermarsi a poco a poco; desiderò di far ritorno fra
i suoi cari, e di chiudere le pupille
fra le braccia dell'affettuosa
genitrice, cui tanto amò; sicchè nel giorno 10 agosto
del 52 estenuato di forze, disformato e col pallor della morte sul sembiante
ricalcava la soglia della casa paterna.
Quivi l'efficienza malefica dell'incognita ed insanabile
malattia più fiera mostrossi, e lo aggravò siffattamente, che
empì i desolati genitori di spavento. Ei solo, come termine
di una lotta crudele ed atroce, vedea la morte con indifferenza,
anzi con gioja ineffabile, perchè la religione lo
avea reso tetragono agli aculei del
dolore; perchè i dolo-ri del corpo
acquistano in chi li soffre una certa sovrumana
dolcezza, quando sono conditi e
sublimati dagli affetti del Cielo; perchè le anime de' giusti sono in mano di
Dio, e non li tocca il tormento di morte ([3]).
Era il dì 21 novembre del 52. Il
giovine non più sentendo sotto la
mano battere il suo cuore, comprese di essere
all'orlo estremo della vita, in cui ogni cosa terrena
si obblia. Non paventò, ma con fermo
animo e con occhio tranquillo vedendo
avvicinarsi la morte, si volse tutto ai supremi
conforti della religione, la quale avea sempre avuta
compagna de' suoi pensieri, complice delle sue speranze
e alleviatrice de' suoi mali. Chiese la paterna benefizione;
e la mano de' mestissimi genitori, che dirottamente piangevano,
si posò sul capo del morente, e lo benedisse.
Nell'ultimo istante volse un debile sguardo ed una imma- di
nostra Donna, la cui Presentazione al Tempio celebrava
in quel giorno Santa Chiesa; e dopo tre anni e sette
mesi di fierissimo sereno patire, rese sorridente l' immacolato spirito al suo
Creatore.
Così
visse e così morì Ferdinando d'Alena, il quale,
se mancato non fosse nel fiore degli anni e delle speranze, sarebbe
stato il decoro e l'ornamento della patria sua. Ma
la Provvidenza con un consiglio pieno
di misericordia lo ha tolto
innanzi tempo alle dolcezze della vita, affinchè la malizia
e la seduzione non avessero indotto l'anima di lui in errore
([4]).
Stagionato egli in breve tempo compì una lun-ga
carriera, conciossiacchè era cara a Dio l'anima di lui;
per questo si affrettò di trarla di mezzo alle iniquità ([5]);
e Dio, dopo di averIo provato, come
oro nella fornace, lo ha ricevuto
come vittima di olocausto ([6]).
Noi intanto curviamo la fronte innanzi a' giudizi imperscrutabili di Dio, e
spargiamo lagrime e fiori sulla tomba dell' estinto.
Florindo
Canonico Battista
Dottore
in S. Teologia
![]()
ALLA CARA MEMORIA
FERDINANDO DE’ BARONI D’ALENA
ODE
Come
dal verde cespite
Reciso
un bianco fiore,
Vizzo,
sfrondato e pallido
Langue
e calpesto muore:
Così
cadesti ... Oh lasso!
Freddo,
funereo sasso
ti
covre ... e non sei più!
Oimè!
dov'è quel candido
Fronte,
e 'l rosato viso,
E
la pupilla vivida
Raggiante
d'un sorriso?
Oh!
dove, alma gentile,
Degli
anni tuoi l'aprile,
Dove
la gioventù?
Tutto
sparì, qual soffio
Di
vento passaggero;
O
come fugge rapido
Un
sogno del pensiero.
Tu
fosti! ... e agli occhi miei
Or
fango ed ossa sei
Nel
fiore dell' età.
-10-
Così
ritorna. in polvere
Ogni
mortale aspetto,
Che,
innanzi quasi angelico,
Divien
schifoso, abbietto:
E
l'urna, alla sua vista
Sì
spaventosa e trista,
Tutto
tremar ci fa.
Ma
tu ridente, impavido
Cangiasti
con gli oscuri
Silenzi
della gelida
Tomba
i tuoi dì futuri:
E
con giocondo aspetto
Lasciasti
il patrio tetto
Per
sempre nel dolor.
Nè
più dalla tua polvere
Farai
qui lieti un giorno
I
cari tuoi, che piangono
Al
tuo sepolcro intorno.
E
spargono sull' urna
Nell'
ora taciturna
Freschi
e vermigli fior.
Ve'
la tua madre pallida,
Che
in mezzo all'aspre pene
Consunta
dalle lacrime,
Al
suoI procombe ... , e sviene.
Squarciata
dal dolore,
Piange
il reciso fiore
Della
tua verd'età.
-11-
E
'l vecchio padre stracciasi
L'augusto
crin canuto;
Chè
nell'età più tenera
Per
sempre ei t' ha perduto.
Tristo,
affannato e stanco
Al
dì crescente e al manco
Di
te parlando va.
Ahi!
misero tra miseri
Di
pianto il ciglio allaga;
Quand'ei
contempla, o giovine,
Te
nel gentil Gonzaga.
Tu
co' color gli desti
La
vita, e gl'imprimesti
Gli
affetti del tuo cor.
Ch'
alma pudica, ingenua
Al
par di Lui nel petto
Chiudevi,
è in cor bolliati
Immacolato
affetto.
E
dolcemente in viso
A
te brillava il riso
Di
vergine candor.
L'
aura de' tuoi santissimi
Costumi
intorno oliva:
Il
fasto e la superbia
Dagli
occhi tuoi fuggiva.
E'l
temerario orgoglio
Non
mai formossi il soglio
Nell'
alma tua gentil.
-
12 -
Ma,
di splendor patrizio
Sdegnoso,
con amore,
Alla
virtù, alla gloria
Solo
schiudevi il core.
E
volto a nobil segno
Il
luminoso ingegno,
Eri
modesto, umil.
Talchè
sembravi un Angelo
Chiuso
in caduca argilla.
Di
crudo morbo il calice
Fino
all' estrema stilla
Acerbo,
invitto fato,
O
caro sventurato,
Sovra
il tuo sen versò.
Eppur
festante, intrepido
In
mezzo al tuo màrtiro
Tu
fosti ... e sciolto un tenue
Dolcissimo
sospiro,
Ai
genitori accanto
Chiudesti
il viver santo,
E
l' alma al Ciel tornò.
Non
dura in questo esilio
Angelico
intelletto.
E
tu passasti celere,
O
vago giovanetto;
Chè
la terrena sfera
Degna
di te non era:
Era
tua patria il Ciel.
-13-
Addio!
diletto giovine,
Tolto
all' età fugace.
Pace
al tuo spirto angelico,
Al
cener tuo sia pace.
Prega
de' Santi il Santo
Per
me che fìori e pianto
Spargo
sul muto avel!.
Florindo
Canonino Battista
![]()
ALLO
STESSO
Poiché di giovinezza
il vergin fiore
Morte recide, e la
più bella speme
Innanzi tempo ne
rapisce; il core
Amaramente piange
e si contrista:
Chè di leggiadre
fantasie, di veri
Magnanimi feconda
è giovinezza,
E d'opre eccelse sovrumane
– E Roma
Il seppe, e Grecia; e Italia
il sa, cui d'ogni
Gloria leggiadra, e d'ogni
bella impresa
Dono facea l'ardita
gioventute.
E l'armi fere,
onde ancor pave e trema,
Se le rammenta,
il domito Emispero;
E i canti, il
foro, le colonne, gli archi,
Le tele, i
simulacri, ond'eran fatte
Appo le genti e gloriose e
chiare,
Venian da mani giovinette e
care
Era pertanto de'
vegliardi primo
Supremo studio
delle giovin menti
La cura, e a
grandi memorande cose
Volger quell'alme
- E la Spartana intese,
E la madre latina
a farli egregi
Fin dalla cuna -
E quando acerba morte
Pel suol natìo,
pe' dolci lari in guerra
Li sospingeva al
Tartaro, piangeva
E Grecia e Roma,
e si covrian di lutto.
Era quel giorno
sconsolato, amaro,
Indizio di
sventura inaspettata!
Irati i patri Numi, il Cielo
irato
Allor pareva, e
gli Astri, e la Natura;
E d'ostie sacre, e
d'odorati incensi
Fumavano gli
altari, e sacri carmi
Eternavan quei
prodi in bianchi marmi.
-
15 _
E noi? Di vitupero e
di vergogna
Fatti
codardo esempio, e di viltate,
Noi
turpemente immemori degli Avi,
A
somiglianza di spregiato armento,
Seguiam
le voglie di costume insano!
E
nelle fasce, e nella verde etade
Spregiam
la piu leggiadra e cara speme,
Onde
la patria attende ogni suo bene.
O
se matura, e bella, e gloriosa
Onora
per virtude il patrio nido
La
contristiam, noi nella tomba oscura,
«Ove
non pietra sorge, nè parola»
La
sotterriamo! O tempi antichi, o cari
Tempi
di gloria, il nero oblìo vi covre;
E
non fia mai che vi riveggia il Sole,
Finchè
spregiam la giovinetta prole!
Pur
fra cotanto strazio, e tanto affanno,
Siccome
fior che solitario spunta
Sovra infeconda
landa, e tutto intorno col grato odore il diserto consola,
Tal tu crescevi
sventurato e caro
In quest'arida
terra; e all'arti belle,
Al dolce e chiaro
dì Sapienza lume
La bell'alma
volgendo e il cor gentile,
Ne rallegravi di
speranza il petto!
Ma in sul fiorir
della più bella etade
Da lento morbo
travagliato, il dolce Ameno incanto, le lusinghe prime
Di quell'età, che
tutto abbella e infìora Vedevi sconsolarsi; e nell' istante
Che il vivere per
te volgea più bello,
Ti raccogliea lo
sconsolato avello.
-16-
Pari
in duolo a quel divo, onde l' Italia
In
suo sermone il greco canto udia,
E
la solenne dignità latina
Nell'
Itala parola rifiorita;
Cui
fu natura indomita nemica,
Ed
il dolor compagno, e la sventura;
Unico
e caro all'età nostra esempio:
Chè
core, e mente sovrumana in terra
Non
sorge, o dura se d'affanni, e mali
Non
fia spettacol miserando e nuovo!
Tal
fu di te; tal fia d'ogni alma bella,
Che
solitaria pellegrina in terra!
E
questo è a noi conforto, o sventurato,
Caro
infelice, che leggiadro spirto,
Poichè
si solve dal corporeo velo,
Torna
a bearsi eternamente in Cielo.
Però
da quella che t'accoglie e inciela
Spera
di luce, a noi rivolgi il ciglio
E
a questa terra neghittosa ov'ozio
E
sonno ingombra le affralite menti;
Che
in giochi vergognosi si trastulla,
Che
si consuma d'odio, e di vendetta,
A
vil guadagno, e solo all' oro intenta;
Ignara
d'arti, e di magnanim' opre,
E
di leggiadri studi, e di sapienza.
Tu
dalla usanza rea, dal turpe oblio,
Nov'
angioletto la ridesta, e in core
Tu
pio le accendi l' immortale affetto,
Che
a grandi cose è sprone; acciò si levi
Dalla
spregiata, fetida belletta,
Ov'ella
poltre, e si rivolga al vero;
Sì
che a grand'opre agogni in suo pensiero.
Giuseppe
Canonico Vago
(mancano le pagine da 17 a 24)
![]()
-25-
Gli
favellavi dell' eterne cose,
E
del Signor, che tutto agita e crea,
Ch'ei
pel cammin del Cielo il piede pose.
Ed
ei quaggiuso un Angelo parea;
E
in Dio rapito il suo bel cor di santi
Religiosi
palpiti battea.
Oh!
come, o donna,' al caro viso innanti
Del
giovine diletto il tuo materno
Cuore
balzava di letizia ! .. oh quanti
Angelici
desir! .. quante all' Eterno
Preci
volgesti per l' amato figlio,
Chè
saldo ei fosse contro il crudo Averno!
E
al Ciel tornasse dal terrestre esiglio
Innocente
qual venne, intatto al Nume
Serbando
il verginal candido giglio.
E
Dio t'udiva, e angelico costume
L'alma
adornò del giovine gentile,
Che
aprì la mente della scienza al lume.
Quindi
in dolcezza a te tutto simìle
Infiammossi
del Bel, del Buon, del Vero
Degli
anni suoi nel più ridente aprile
Ei
fu sobrio, leal, casto, sincero
Per
te, sola per te, che lui traesti
A
celeste santissimo sentiero.
Nell'
aspra pugna del dolor tu desti
A
lui coraggio, ed inclita costanza,
Che
alleggia dalla doglia il cor de' mesti.
-26-
Del
cor materno, che soave india
E
leva i figli a nobile onoranza!
Nella
più verd'età così fioria
Il
prode giovanetto a te daccanto
Tutto
gioia, innocenza e leggiadria.
E
tal dagli occhi tuoi suggeva incanto,
Che
a lui sembravi, o mesta genitrice,
Diva
ravvolta nel terreno ammanto.
E
al guardo suo per te questa infelice
Scena
del mondo gli sorrise in vista
Di
paradiso, e fu per te felice.
Tutto
cangiossi, in un momento! .. e trista
Ti
veggo, o donna; e la tua rea sventura
Mi
sforza al pianto ed il mio cor rattrista.
Ah!
in mezzo al quinto lustro un' immatura
Morte
crudele t' ha rapito il figlio,
Che
te beava in questa selva oscura.
Ei
si letizia in Ciel; ma in questo esiglio
Te
nel pianto lasciò, dal suo terreno
Carcere
uscendo e dal mortal periglio.
E
tu ti squarci per la doglia il seno;
E
'l crin ti stracci, e disperatamente
Alle
lacrime tristi allarghi il freno.
E
piangi, come tortora dolente,
La
bella giovinezza e 'l vago fiore
De'
suoi poveri di, che sì repente
-27-
Cadde
reciso con crudel furore
Dall'
empia morte; e in bruna vesta: avvolta
Sospiri,
e con la man ti stringi il core.
Caduta
è la tua gloria; e in pianto è volta
Ogni
tua gioia: e misera qui sei,
Chè
ogni dolcezza di tua vita è tolta.
E
ben ti duoli, e ben con tristi omei.
Bagni
di calde lacrime le guance ...
Folle!
che dissi? No ... piagner non dei:
Perchè
se libri omai con equa lance
Le
cose di quaggiù, tutto è sozzura,
E
l'altre cose son fallaci ciance.
Al
giusto, o cara, il vivere è sventura,
Grazia
il morir; chè all' anime gentili
La
morte è fin d'una prigione oscura.
Han
poca gioia del sepolcro i vili;
Ma
innanzi al ferro della Parca irata
Ridon
l'alme magnanime virili.
E
del tuo figlio l'anima: beata
Di
gioia sfavillò nell' ultim' ora,
Chè
al Ciel reddìa, qual giglio, immacolata.
Pon
freno adunque al duol che sì t'accora:
I
lunghi affanni dal tuo petto sgombra:
Chè
un bel morir solo la vita onora.
Se
acerba doglia il seno ancor t'ingombra,
Pensa
che l' alma sol non può morire;
Il
resto è vanità ... polvere ed ombra.
-
28-
Guarda
il suo capo d'un bel serto adorno,
Cui
di morte la man non può rapire.
Ei
lieto. in grembo a Dio fece ritorno,
Chè
in questa valle perigliosa, oscura,
Di
rea nequizia e d' empietà soggiorno,
»
Cosa bella mortal passa e non dura.
Florindo Canonico Battista
FINE
![]()
([2])
Ecdesiast:
cap: 1.